La Seconda Guerra Punica. Le cause dello guerra
- Giovanni Melappioni

- 26 mar
- Tempo di lettura: 8 min
Lo scontro che vide contrapposte Roma e Cartagine dal 218 al 202 a.C., prima ancora che con il canonico nome di Seconda Guerra Punica, può essere definito una guerra annibalica, tanto decisivo fu il peso del condottiero punico sull’intera vicenda. A tal punto che lo stesso Polibio dice che “quanto accadde a entrambi i contendenti fu opera di un unico uomo e di un’unica persona: Annibale” (Polibio, Storie, IX 22). In effetti, per buona metà del conflitto Annibale dettò il passo agli eventi, anche se non sempre traendo beneficio da questa libertà d’azione.

La guerra fu diretta conseguenza della prima prova di forza fra Roma e Cartagine, che noi ricordiamo come Prima Guerra Punica (264 - 241 a.C.). Le indennità richieste dai Romani, che ne uscirono vincitori, influenzarono il corso dei successivi anni in maniera decisiva. Amilcare Barca, il più influente membro della famiglia che subì la grande sconfitta in quel primo conflitto, propose di spostare l’asse strategico verso la Spagna, territorio sede di antichissime colonie fenicie e con grandi potenzialità di espansione, soprattutto per la sua sufficiente distanza geografica e politica dal nemico italico. Roma, infatti, era impegnata nel settentrione della penisola italiana e non aveva interessi né appoggi in quell’altra parte del mondo. Il senato appoggiò la proposta, d’altronde non c’era altro modo di procedere. Possiamo essere certi che l’orgoglio nazionale giocò un ruolo importante nella decisione di cominciare le ostilità in terra iberica, ma non c’è prova che l’intero progetto fosse rivolto allo scontro diretto.

Nel 237 a.C. Amilcare sbarcò in Iberia conducendo con sé il genero e il figlioletto Annibale, all’epoca di nove anni, e un numero di senatori con i quali creare una sorta di governo provinciale dalle forme a noi sconosciute nelle dinamiche operative, ma sicuramente legittimato a prendere decisioni nell’immediato, come la campagna militare attiva abbisognava. Quella dei Barca era un’impresa di famiglia, ma il legame con Cartagine rimaneva fondamentale, soprattutto dal momento che non erano pochi gli oppositori al progetto iberico, guidati da Annone, più interessato a rafforzare l’entroterra africano, anche per tutelare interessi commerciali in buona parte rivolti verso Roma.
Nel corso di sei intensi anni di espansione, Cartagine ottenne territori vastissimi nell’odierna Andalusia; inoltre, un’importante fortezza punica fu costruita nei pressi dell’attuale Alicante. Roma non aveva alcun interesse verso quell’area del mondo, tuttavia, la sua alleata Marsiglia si considerava in prima linea e si rivolse alla potente città italica affinché si facesse chiarezza sulle operazioni puniche nell’area che confinava con le sue colonie di Emporion e Rhode. L’ambasceria raggiunse Amilcare nel 231 a.C. e agì più per tranquillizzare i marsigliesi che per minacciare i Punici. Gli inviati si ritennero soddisfatti dalle risposte di Amilcare, il quale puntò soprattutto sul rimarcare la volontà di Cartagine di onorare il debito nei confronti di Roma, debito che fu in effetti saldato in quell’epoca grazie alle miniere d’argento che aveva portato sotto il suo dominio in Iberia.
Se l’ambasceria del 231 fu quasi una pura formalità, di maggiore impatto si rivelò la successiva delegazione, giunta a Cartagine nel 226. Questa volta ad accogliere i messi romani c’era Asdrubale, succeduto al comando delle forze cartaginesi alla morte di Amilcare, avvenuta nel 229. In questa occasione Roma intervenne con maggiore decisione. Il comandante punico aveva infatti esteso il suo dominio nell’area tramite azioni militari e un’abile attività diplomatica. Come risultato, tre colonie marsigliesi erano cadute nelle sue mani. Per tutelare le altre, il trattato che fu siglato in quell’occasione poneva come limite non oltrepassabile da un esercito cartaginese proprio l’Ebro. Sempre in questa occasione, inoltre, anche se non abbiamo una data certa, Roma strinse rapporti con la città di Sagunto, che era ancora indipendente.

Nel 221 Annibale, figlio di Amilcare, succeduto ad Asdrubale in seguito alla morte violenta di quest’ultimo per mano di un celta, venne chiamato a dirimere una questione sorta fra Sagunto e i suoi vicini, appartenenti a una confederazione iberica che faceva capo alla potenza cartaginese nell’area. Annibale, alla ricerca di un casus belli, accettò invitando entrambe le parti a presentarsi a lui, riconoscendolo in tal modo come autorità superiore. Gli iberici già asserviti non ebbero problemi, ma i magistrati saguntini rifiutarono l’invito temendo, a ragione, di perdere l’amicizia e la protezione di Roma se avessero accettato l’arbitrato di Annibale. Dopo aver ripetuto l’invito invano, Annibale accusò apertamente Sagunto di essere nel torto, presentandosi come giustiziere per conto della lega di Iberi che si erano rivolti a lui, e mosse contro la città iberica.
All’inizio delle operazioni, quando la terza ambasceria romana lo raggiunse a Carthago Nova, sua base operativa, egli lasciò che le minacce dell’eterna rivale scivolassero sulla sua volontà di ferro. Annibale doveva essere ben consapevole delle conseguenze delle sue azioni, perché rispose sprezzante alle parole degli ambasciatori, congedandoli con un nulla di fatto. Il giovane condottiero diede poi immediato inizio alle operazioni militari contro la città iberica. Nel 219, dopo averla privata di tutto il suo territorio, Annibale giunse a porre l’assedio finale a Sagunto.
Nei nove mesi che precedettero la caduta di Sagunto, Roma non intervenne. Le fonti sembrano indicare uno scollamento tra l’oligarchia di governo, più interventista ma non coesa, e il popolo, desideroso di pace, sin dall’inizio della crisi saguntina. Due anni e la distruzione della città iberica furono sufficienti, però, per un capovolgimento politico decisivo, con tutte le parti indignate dalle azioni di Annibale e, con tutta probabilità, in imbarazzo per aver sottovalutato gli eventi in Iberia. La fine di Sagunto minava la credibilità di Roma come apice della grande coalizione che essa stessa aveva creato in secoli di scontri con gli Italici. Era necessario prendere l’iniziativa; la guerra sembrava imminente e, anzi, desiderata, visto che per l’anno 218 vennero eletti dai comizi due consoli avversi a Cartagine: Publio Scipione, padre del futuro Africano, e Tiberio Sempronio Longo, che avevano già ben chiara la strategia militare da intraprendere contro Cartagine, tanto da essersi divisi i teatri operativi della guerra che volevano e che ritenevano inevitabile a quel punto.

Occorreva soltanto formalizzare l’intervento attraverso la diplomazia, e qui ebbero voce coloro che ancora cercavano una soluzione soddisfacente, ma pacifica, con la potente città africana. L’impulso a questa linea d’azione venne dalla potente famiglia dei Fabii. C’erano interessi economici e politici, ovviamente. Roma, in quel tempo, era impegnata nella difficile conquista della Cisalpina. Lassù i Galli erano irrequieti, ancora lungi dall’essere innocui, nonostante le sconfitte subite nel decennio precedente. Grandi interessi muovevano parte dell’oligarchia in direzione dell’Italia settentrionale, e un conflitto mediterraneo era quanto di più estraneo si potesse presentare loro. I delegati inviati a Cartagine si auguravano di poter indurre l’oligarchia fenicia, con cui avevano contatti molto intensi da anni, a prendere una posizione netta nei confronti delle azioni del loro generale. Un risultato impossibile da ottenere, visto che il popolo punico era da anni entusiasta dei trionfi dei Barca, e la grande riscossa, che forse nessuno aveva davvero paventato fino a quel momento tranne lo stesso Annibale, era divenuta una concreta possibilità. L’ingerenza di Roma in un’area così lontana dall’Italia fece emergere uno spirito nazionale che voleva la guerra e che trovò in Annibale il suo campione.
Facevano parte della deputazione capeggiata da Marco Fabio Buteone nomi di grande prestigio, tra i quali Lucio Emilio Paolo, il futuro console morto a Canne, e l’uomo della nostra monografia, Quinto Fabio Massimo. Secondo Tito Livio, nel libro XXI della sua storia di Roma, Ab Urbe Condita, giunti a un punto di stallo nelle discussioni, Massimo afferrò il lembo della sua toga creandovi una piccola sacca che indicò gridando: “Qui vi portiamo sia la pace che la guerra, a voi scegliere tra le due”. Il senato di Cartagine all’unisono rispose di compiere esso stesso la scelta, se ci teneva, e con gesto enfatico Massimo sciolse la tunica dal petto e dichiarò che allora sarebbe stata la guerra. Non deve stupire il fatto che la compagine romana, partita con l’intento di evitare lo scontro, l’abbia poi di fatto provocato. Fabio Massimo e gli altri avevano sì degli interessi, dei legami e delle connivenze politiche con alcune frange del senato cartaginese avverso ai Barca, ma tale partito aveva perso potere in maniera proporzionale a quanto ne acquisivano i Barcidi con le loro vittorie e l’influenza che ne derivava. Di fronte a questi fatti, il patriottismo e l’orgoglio dei Romani giocarono un ruolo importante, insieme alla rivalutazione degli assetti politici dell’antica nemica, tanto da arrivare allo sprezzante ultimatum di Quinto Fabio Massimo.

Terminata la missione diplomatica, Quinto Fabio Massimo e gli altri fecero un ampio giro prima di rientrare a Roma. Si recarono in Spagna e nel sud della Francia, per cercare alleati e sostegno tra le popolazioni autoctone. È molto interessante, ai fini di una comprensione migliore degli eventi che seguirono, osservare come la missione ebbe uno scarsissimo successo. I sentimenti generali davano l’idea di una propensione per Cartagine, sia per la vicinanza dei suoi eserciti, sia, soprattutto, per l’impressione negativa che l’abbandono di Sagunto aveva provocato nelle altre popolazioni iberiche ancora in grado di esprimere una libera scelta di campo. Furono i Volciani a dare voce a quel malcontento che doveva essere generalmente condiviso, perché dopo che gli ambasciatori romani furono trattati con durezza e scacciati dalle loro terre, nessun’altra tribù iberica volle incontrarli. Andò anche peggio con i Galli, che si rifiutarono di impedire ad Annibale il passaggio verso l’Italia. Non avrebbero combattuto per Roma contro un generale che non era stato loro nemico. Massimo e i suoi ricevettero ben poco supporto. Questa acrimonia dovette verosimilmente aumentare in Annibale la sua fiducia nel piano stabilito.
Un simile clima di ostilità deve aver influenzato Annibale, dandogli l’illusione di una situazione di oppressione e generale disaffezione nei confronti di Roma anche da parte degli altri popoli a essa soggetti. Nella sua testa, gli Italici non potevano avere migliore opinione sui Romani di Galli e Iberici. Il suo arrivo, e la sua liberazione, sarebbero stati salutati con entusiasmo. Gli storici antichi sono chiari nello spiegare come la lunga marcia di Annibale verso l’Italia non fosse certo un gran mistero per Roma; non fu quell’azione di sorpresa che a volte si tenta di enfatizzare. La sorpresa, semmai, fu nelle tempistiche di esecuzione, ma si tratta di un piano differente di analisi. I piani dei consoli eletti quell’anno parlavano di azioni offensive su due fronti: l’Africa, passando dalla Sicilia, e la Spagna, partendo da Pisa e costeggiando i litorali amichevoli della Francia meridionale. Annibale aveva passato l’inverno a inviare contingenti dall’Iberia verso l’Africa e viceversa, per rafforzare le guarnigioni utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione: mercenari, contingenti alleati e contingenti estorti con la forza e, proprio per questo, inviati così lontano dai luoghi d’origine da non consentire alcuna forma di insubordinazione. In questo frangente, è lecito domandarsi se avesse già concepito la sua incredibile offensiva. Doveva affrontare il viaggio via terra, attraverso i possedimenti di tribù barbare che non gli erano amiche pur senza mantenere rapporti con i suoi rivali. Era un azzardo che decise al sopraggiungere di alcune notizie dall’Italia stessa. L’indignazione che aveva attraversato l’opinione pubblica romana e, per esteso, il suo corpus politico, dovette sembrargli l’eco di un più diffuso sbigottimento per come la città laziale aveva gestito i suoi rapporti con un amico. La distruzione di Sagunto era stata, per colpa degli scarsi mezzi ossidionali di Annibale, un affare protrattosi per mesi. Fosse stato un colpo di mano improvviso, forse le voci che si sarebbero levate avrebbero invocato vendetta nei tempi e nei modi stabiliti da Roma. Ma l'assedio di Sagunto e la sua lunga agonia appariva come un tradimento. Non sarebbe forse apparso come un segno del Fato che giungessero, per mano di Annibale, anche delle sconfitte militari decisive a decretare la fine della supremazia romana?
Il condottiero cartaginese, per come le fonti narrano le sue azioni, era convinto di dover davvero rischiare il tutto per tutto in Italia, come dicevamo, quando constatò con i propri occhi i risultati dell’ambasceria romana in Iberia. Ripartiti i Fabii e gli altri, Annibale radunò un esercito enorme e si mise in marcia verso l'Italia.
La guerra più devastante e decisiva del Mediterraneo antico era iniziata...
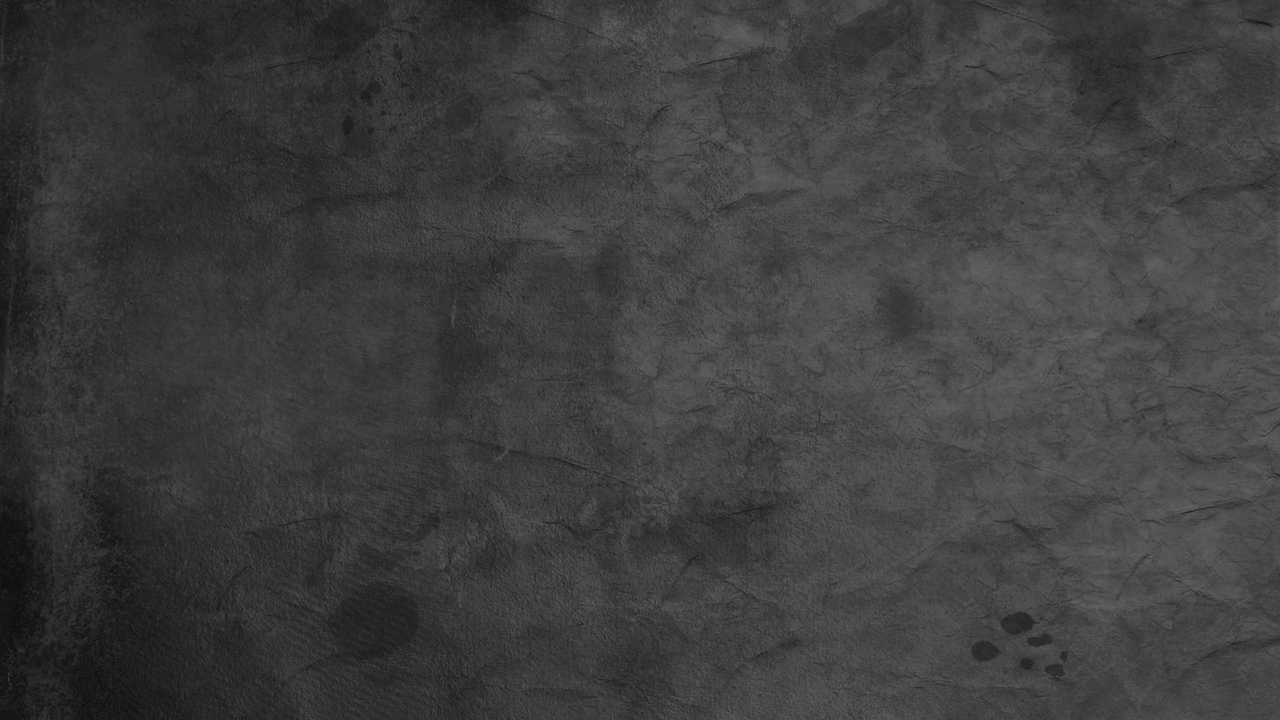



Comments